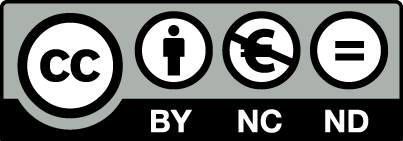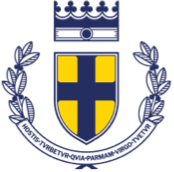1943 - 1947
Tratto da: "VIGILI A PARMA - DALLE GUARDIE DI BUONGOVERNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE. STORIA DI UN’ISTITUZIONE", Umberto Bonomini e Roberto Spocci, Casa Editrice Luigi Battei, Parma, 1995
Le difficoltà del periodo bellico si ripercossero anche sul corpo dei vigili. In una lettera, indirizzata al Prefetto nel maggio 1943, il Podestà rimarcava come ad un organico di 83 vigili rimanevano a disposizione del Comando solamente 7 vigili per i servizi generali.
L'organico era costituito da 83 operatori cosi ripartiti: 1 Comandante, 1 Vice Comandante, 7 graduati, 74 vigili.
Tolti i richiamati alle armi erano disponibili 59 agenti, di questi 30 erano così assegnati: 8 alle funzioni di informatori, 6 al servizio razionamento, 4 ai servizi annonari, 3 all'ufficio di Polizia Urbana, 7 alla Questura, 2 alla vigilanza sanitaria. Dei rimanenti 29, 1 risultava sospeso dal servizio, 1 era in aspettativa , 4 risultavano assenti per turni di riposo, 2 erano in licenza, 2 risultavano assenti per malattia, 1 era comandato di servizio al Macello Pubblico, 7 erano assegnati al Corpo di Guardia, 3 al Mercato di Piazza Ghiaia ed 1 distaccato quale informatore all'Ente Comunale di Assistenza. Rimanevano disponibili per i servizi generali solamente 7 agenti chiaramente inadeguati per provvedere ai normali compiti d'istituto (ASCPR, Carteggio, Polizia 1943)
Tale penuria di agenti rendeva impossibile soddisfare alle quotidiane richieste delle autorità per assolvere compiti speciali.
La notte dell' 8 settembre 1943 il servizio in Corpo di Guardia era svolto, come al solito, da un brigadiere e tre vigili allorché si presentò un drappello di soldati tedeschi che, al comando di un ufficiale, presero possesso del Corpo di Guardia e, dopo un attento controllo, occuparono tutto il Comune.
Dal Corpo di Guardia trasformato in avamposto delle truppe d'occupazione, i tedeschi intimarono la resa al Presidio Militare, alloggiato nel Palazzo del Governatore, dando il termine perentorio di venti minuti per cedere le armi.
Nel frattempo fatti affluire rinforzi e circondate caserme e posti di polizia i tedeschi piazzarono tre cannoni, uno all'imbocco di via Farini, uno nell'attuale Strada della Repubblica ed un terzo in via Mazzini. Trascorso il breve periodo di tregua vennero sparate due cannonate contro il Palazzo del Governatore costringendo il Presidio alla resa. La mattina seguente per ordine del Commissario Prefettizio tutti gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale vennero posti agli ordini del Comando tedesco ed intorno alle ore 9 della mattina del 9 settembre 1943, inquadrati come reparto in formazione, una trentina di vigili percorsero via Cavour e via Melloni per recarsi nel cortile della scuola Pietro Giordani; al passaggio dei vigili scortati da militari tedeschi si sparse in città la voce che sarebbero stati tradotti in Germania. Ma giunti alla " Pietro Giordani" un ufficiale tedesco tenne loro un discorso per indurli ad affiggere nei punti nevralgici della città il manifesto che annunziava il coprifuoco; inquadrati come polizia cittadina alle dirette dipendenze del Comando Militare germanico, i vigili furono per circa venti giorni le uniche forze di polizia presenti in città (questa testimonianza sulle vicende dell'8 settembre 1943 fu resa dall'ex brigadiere Francesco Triani agli autori del libro citato in epigrafe).
Ogni qualvolta si verificava l'allarme aereo, tutti i vigili fuori servizio dovevano presentarsi al Comando del Corpo e permanervi fintanto che l'allarme cessava (Ordine di servizio del 7 novembre 1943). Inoltre nuove esigenze si erano determinate in conseguenza di severi controlli sulla circolazione stradale conseguenti allo stato di emergenza e per l'ampliamento del territorio comunale (con la legge 14 aprile 1943, n. 337 furono aggregati al Comune di Parma i comuni del forense portando la popolazione da 79987 a 116790 unità). Per ovviare all'inadeguatezza numerica del Corpo si deliberò, il 13 novembre 1943, l'assunzione di 20 vigili urbani. Questi furono assunti provvisoriamente fino al dicembre del 1944.
Nel 1944 il Comandante dei Vigili Giovanni Bosi lasciò il comando del corpo per assumere quello della locale Polizia ferroviaria e, a sostituirlo, venne chiamato un funzionario del Comune, il rag. Angelo Testa, già dirigente del Comune di San Pancrazio e capomanipolo delle CC.NN.
Gli agenti, già ridotti di dodici uomini perchè richiamati alle armi, risultavano interamente mobilitati, anche fuori orario per soddisfare alle normali necessità d'istituto e per I servizi d'emergenza, come la ricerca degli alloggi per i sinistrati, la guardia alle macerie e la vigilanza agli sbarramenti. Da tali servizi straordinari, in un rapporto del Commissario al capo della Provincia in data 16 maggio 1944, viene chiesto l'esonero per il Corpo, perchè servizi armati mentre gli agenti municipali chiamati ad assolverli erano disarmati. Nello stesso giorno si decise di trasferire la sede municipale, sinistrata e resa inservibile dai bombardamenti, da piazza Garibaldi al Municipio del soppresso Comune di San Lazzaro (Deliberazione n. 298 del 16 maggio 1944) . A San Lazzaro venne accolta la rappresentanza e la Segreteria del Comune mentre altri uffici e servizi vennero sistemati in locali diversi. Il Comando dei Vigili Urbani venne trasferito nella sede di via Casa Bianca al n. 5.
I Vigili e la resistenza
Alla lotta partigiana due nuclei di vigili operarono nella clandestinità, il primo formato da una squadra SAP composta da Gino Bernardi (responsabile del nucleo), Bruno Castelli, Gino Anelli, Arnaldo Negri, Gaetano Buttini e Pierino Gorreri che prendevano ordini da Pilade Cremonesi incontrandosi nel retrobottega di una stireria di via Nazario Sauro gestita da Alice Bianchi, poi consorte del Bernardi. Il secondo nucleo partecipava al SIM-SIP ed era formato da alcuni vigili comandati presso le amministrazioni “repubblichine”, a questo nucleo appartenevano Eliandro Elisei e Icilio Manfrini. Fra i loro compiti vi era la propaganda con distribuzione di volantini e scritte murali, la fornitura di documenti falsi ai renitenti e gli allarmi per sventare le retate dei nazifascisti.

9 dicembre 1947, Piazza Garibaldi, sul palco (2° da destra) il Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola durante la cerimonia per il conferimento della Medaglia d'oro al Valor Militare alla Città di Parma. Ai piedi del palco lo schieramento dei vigili urbani.
Nel video il Presidente De Nicola appunta la MOVM al Gonfalone della Città di Parma.
La motivazione della Medaglia d'Oro al Valor Militare: Fiera delle secolari tradizioni della vittoria sulle orde di Federico Imperatore, le novelle schiere partigiane rinnovavano l’epopea vincendo per la seconda volta i barbari nipoti, oppressori delle libere contrade d’Italia. L’impari lotta, sostenuta con la stessa fede dei padri e col sangue dei figli migliori, cominciava per merito dei primi volontari della libertà all’alba del 9 settembre 1943 e si concludeva il 25 aprile 1945 con la sollevazione del popolo tutto che, affiancando i settemila e cinquecento fratelli partigiani combattenti, costrinse alla resa e vide la fuga del nemico. L’ombra del glorioso gonfalone ornato dell’aurea gemma del valore riconosciuto dalla Patria grata, aleggia e custodisce la sacra memoria dei seicentonovanta quattro caduti con le armi in pugno per la redenzione dell’Italia, dei quattrocento sepolti sotto le macerie della città straziata dai bombardamenti aerei, che, unitamente ai cinquecentotredici feriti, mutilati e invalidi, ai ventuno dispersi, ed ai centonovanta deportati nelle gelide e mortifere lande dei paesi stranieri, costituirono la parte eletta del popolo che seppe difendere e riconquistare le patrie libertà. 9 settembre 1943 - 25 aprile 1945.

25 aprile 1953, Sala consigliare, i vigili urbani svelano la targa sulla quale è impressa la motivazione della Medaglia d'Oro al V.M.