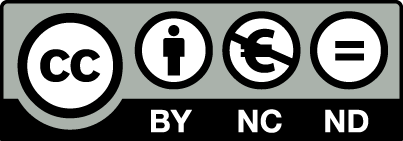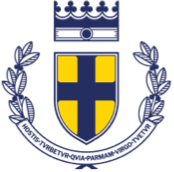1875 - 1903
Il regolamento approvato nel 1875, che modificava il precedente, oltre ad introdurre la delega all’assessore, la figura del vice Commissario ed una struttura amministrativa a sostegno del servizio, sancì nuovi requisiti per essere ammessi nel Corpo quali l’altezza di un metro e settanta, la cittadinanza e l’assolvimento degli obblighi militari, ma la clausola più importante era la condizione di celibe o vedovo senza prole che accompagnava la nomina per l'arruolamento volontario di cinque anni.
La nuova organizzazione prevedeva l’alloggio in quartiere, la mensa in comune, l’assistenza sanitaria e la percezione della metà dell’introito derivante dalle multe.
Dopo l'adozione del Regolamento, le Guardie mantennero il Corpo di Guardia nel palazzo Municipale e si acquartierarono nel palazzetto di San Rocco. Il Palazzetto venne liberato dagli affittuari per acquartierarvi le Guardie; nel 1875 vi si installò un primo nucleo composto da Formaggini Ernesto, Brigadiere e le guardie Celso Peracchi , Medardo Baroni, Enrico Patt ini, Paolo Adorn i, Romeo Magnani, Ferdinando Pagani, Lorenzo Contini e Odoacre Quarantelli cui seguirono nel 1877 Fabrizio Poli, Brigadiere e le guardie Ausonio Dalla Turca, Paolo Maestri, Carlo Baldi, Guglielmo Reggiani, Pietro Castellari, Vittorio Castelli, Ernesto Galluzzi, Giuseppe Ferrari e Vincenzo Contini. I documenti anagrafici registrano un terzo nucleo di Guardie a partire dal 1883 e formato da Attiglio Pollastri, Lodovico Ronchini, Eugenio Chiari, Ercolano Bacchi e Napoleone Galluzzi (ASCPR, Censimenti della Popolazione 1865-1871 , scheda ad vocem Caserma delle Guardie Municipali in strada Malcantoni).
Nel 1880 una disposizione ministeriale impose al Corpo dei Vigili di prestare il servizio notturno di pubblica si curezza. Il Commissario, Guglielmo Cavazzini, in una relazione al Sindaco faceva rilevare (ASCPR, 1880 , Polizia 1, b. 577. Relazione del 26 ottobre 1880) come "il numero delle guardie che si potrebbero destinare per le perlustrazioni notturne si limita a sei, ne potrebbe il numero stesso aumentarsi se non con pregiudizio" dei servizi che le guardie dovevano compiere quotidianamente. L'organizzazione proposta dal Commissario prevedeva che una pattuglia di due guardie perlustrasse dalle ore 14 alle 22 un certo numero di strade loro assegnate, mentre le altre quattro guardie avrebbero espletato il medesimo servizio, divise in due pattuglie, dalle 22 alle ore 2 del giorno successivo, mentre la 1 pattuglia avrebbe svolto il servizio di piantone. Per il servizio diurno il Commissario proponeva d'affidarlo a quelle guardie che già vigilavano lungo le strade o i mercati; inoltre Cavazzini concludeva che per i nuovi servizi si rendeva necessario "...che le Guardie siano armate delle revoltelle ... che dovrannosi consegnare soltanto quando incominceranno il servizio loro comandato e dovranno poi restituirle cessato che sarà il servizio medesimo" .
Il numero delle Guardie Municipali risultava sempre in difetto in relazione alle necessità richieste dai compiti di polizia urbana. Per ovviare a tale carenza organica, durante il dibattito sul Regolamento dei Pompieri Comunali, il consigliere Faustino Pellegri - nella seduta del 4 marzo 1881 - propose di unificare il Corpo dei Pompieri con quello delle Guardie Municipali.
La soppressione dell'obbligo del celibato e del casermaggio saranno approvate, all'unanimità, dal Consiglio Comunalenella nella seduta del 31 gennaio 1890.

Anonimo, Bozzetti per la divisa proposta per le guardie comunali, acquerello, 1875, ASCPR

Nell'immagine la guardia Lodovico Contini e la sua famiglia, 1900 c.a. (collezione privata)
L' alba del nuovo secolo vedeva sorgere le giuste rivendicazioni di migliori condizioni di vita per i lavoratori ed anche i vigili avanzarono le loro richieste. La lettera inviata al Sindaco di Parma, in data 8 settembre 1904 ricorda più le suppliche che non le rivendicazioni sindacali in senso moderno, ma i temi che sono oggetto della richiesta promuovono la compattezza dei vigili che, con la firma del Brigadiere capo Secondo Parigi in testa alle altre, chiedono: la concessione a vestire l'abito borghese nelle ore in cui non prestano servizio; di poter fruire di un periodo di licenza ordinaria non inferiore a 12 giorni e, in particolare, si chiedeva che ogni campagna di guerra od ogni anno di servizio nell' esercito o nella Finanza venissero considerati come un anno di servizio nel Corpo.
Aumenti salariali e nuove condizioni normative verranno concesse al Corpo con il Regolamento del 1907.
Una modificazione al regolamento venne introdotta nel 1903 con la creazione di n. 11 guardie-pompieri; queste ultime seguivano per alcuni servizi, il regolamento del Corpo, mentre per altri quello speciale dei pompieri; infatti, quali guardie dipendevano funzionalmente dagli uffici del Commissariato mentre, come pompieri, erano alle dipendenze dell'Ufficio d'Arte.
L'amministrazione comunale aveva provveduto alla istituzione di queste figure miste di guardie-pompieri in quanto il servizio di spegnimento degli incendi risultava totalmente inadeguato in mancanza di un corpo stabile di pompieri, essendo questi degli operai, che, in cambio dell'alloggio e di una indennità di servizio, si presta vano ad accorrere rapidamente in caso di incendi.
Un corpo stabile di pompieri rappresentava comunque un onere troppo elevato per il bilancio comunale in relazione alla " fortunata scarsità di incendi notevoli nella nostra città" ed inoltre i suoi componenti avrebbero avuto ben poco da fare, si valutò quindi d'affidare alle guardie municipali, dopo un periodo di addestramento, anche il compito di accorrere per lo spegnimento degli incendi. Dopo una prima trasformazione di tutto il corpo in guardie-pompieri ci si accorse, nell ' arco di un biennio, che l'unificazione dei servizi non era funzionale.