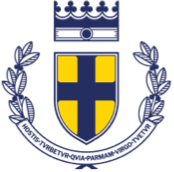Polizia Locale
Il Corpo di Polizia Locale svolge attività di polizia amministrativa e attività di prevenzione e controllo sui fenomeni di illegalità e di inciviltà diffusa nel territorio comunale.
Contatti
INTERVENTI URGENTI
Tutti i giorni dalle ore 07.00 alle ore 01.00 al numero
(digitare il tasto “1” relativo alle urgenze)
RICHIESTE non urgenti e/o INFORMAZIONI
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.30
Il sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00
SEGNALAZIONI non urgenti
Attraverso la piattaforma Comuni-Chiamo